By FRANCA MANCINELLI.
Translated from the Italian by John Taylor.
IT IS INSCRIBED in the birth registry office and on every document that belongs to me: Maria, the name I have deleted from this Franca that remains. It has vanished from my signature. A single name: two syllables that express me, that remove me from silence. Two are already a lot in order to exist. And others’ voices acknowledged me by simply calling me Franca: they stopped there, as if there were no need to say anything more.
Maria is the name of my mother’s mother. I like listening to the echo of this word, the depths that open out, through the generations, like a thread passing through darkness. Through this repetition, I seem to bring her back to life, to give her what belongs to her, her due; it has to do with something endless that sinks behind me until it reaches that which is neither visible nor known to me. From me, beyond me, I do not know how and if it will continue.
She is the mother of my mother, of my mother, of my mother. As if telling rosary beads, I could keep repeating it until it turned into a speechless expression, a sound wave coming in and going back to silence. Maria is the name that every woman wears. And indeed in our Marche countryside there has never been a mother who did not give her daughter this name, as an invocation, as a thanksgiving. If it was not as a first name, then as a middle name, to keep watch over her.
But I will call Mary, my mother’s mother, also grandmother, with my childhood affection intact, framing her in those years of her life when we knew each other. I would often fall asleep next to her, in the middle of the bed that belonged to her husband, who passed away when I was four. As I was lying on the thick linen sheets and before closing my eyes, her words would take on the shape of circles in silence; her bosom was a book of unnumbered pages that ended at one step from sleep. The book would begin again in the morning, as I followed her around while she was doing her housework in the kitchen, in the cellar, in the henhouse. Among the series of sounds that she repeated by heart were prayers. Besides these, she taught me a gesture that resembled that of tying shoes: a crisscrossing movement, if performed exactly. The fingertips touch the center of the forehead, the center of the chest, the left shoulder and then the right one. Like a string that ties you together, that pulls you back to the center of your heart, which is always someone else’s heart. Whenever something begins, whenever you head off somewhere, you make this sign of the cross, as if you were on a shore, on wet ground, in front of misty glass or anything else that might be written on. It means: I’m here, at this exact point. And also: I entrust myself to this time and to this space, to this moment and to this place. Don’t let me go astray, keep me closely in sight. I cannot say who might read this message. I know it’s a sign that soon fades away, that we have to repeat all over again. It’s a bit like tying your shoes in the morning to go out. If later, during the day, you find them untied, you cannot go on very far; you have to stop for a moment and retie them.
During the last years of my grandmother’s life, before falling asleep, she would ask for “the blessing,” a small cross that another person had to mark on her forehead.
During the last years of my grandmother’s life, before falling asleep, she would ask for “the blessing,” a small cross that another person had to mark on her forehead. A very painful bone disease made her call out for her mother, repeatedly. We would hurry in to see what she wanted, what she needed; she would often ask us to move the curtain a little, to bring something closer, but often it was just an excuse to see us next to her. When I was a teenager, I was almost used to this litany, and whenever it seemed a mere whim I soon returned to whatever I was doing. She would call out for her mother, but we were only children, children of children, and we could not console her, lift her up in our arms, hold her tight, away from the pain.
One night, as I rushed over in a bad mood to her childlike cries, with my withheld irritation asking what’s the matter?, I heard myself being beckoned to give the blessing for the first time. No one else was at home. My mother had left, forgetting to give it. It was up to me. To me who no longer believed, who had lost this gesture that she had handed down to me, as you might lose an old key whose door you cannot remember. Could I do it? Was I capable? Lying in bed, she could not give herself over to sleep. She was waiting. Waiting for me. Within the silence, she was entrusting me with a power. I approached from the back of the room and, with my finger, traced a small cross on her forehead. She seemed soothed, reassured. I returned to my room.
THERE ARE TWO roads that go from Lucretia to Cartoceto. You cross an area of recent pastel-colored residential houses, until a fork with two signs indicates the same destination. I always take the left route, which seems shorter. Before arriving at the village, the road rises to Salomone, a name that keeps repeating itself in the mind as it searches for something recalling the ancient Biblical king, all the way to the small cluster of houses where the road curves and begins skirting along olive orchards and a large walnut grove. Soon you arrive at a T-junction: the road from which we have come leads to Lucretia; the road we will take, on the right, to Cartoceto; the one on the left to Saltara and Calcinelli. Here there is a monument to soldiers fallen in the First and Second World Wars: a small palish temple whose inner walls are covered with small, oval, black-and-white photos and inscriptions referring to three kinds of death: from wounds, from illness, from captivity. The places: from Albania to Africa, from Russia to Crete. On the central wall a stone slab reproduces, in relief, the image of Our Lady of Graces.
It is for her that I have come up here today, about fifteen kilometers from Fano, following by car the road up which my grandmother walked ever since she was a child. The miraculous fresco painting was in fact originally located at this crossroads, in a shrine, before being detached and placed in the Sanctuary next to the village. I recognize the lineaments of that ancient painting, so often found at home on my grandmother’s bedside table, in a book, or on a sideboard. A small holy picture like a bookmark, a flower crushed between pages: a reminder of the point to which life has brought you, the point from which you can continue. Soon I will find its colors of grass, dust, and earth in the small chapel built for the Madonna, its walls adorned with silver hearts. I do not stay long. In these monuments to soldiers fallen in battle, I often feel something strange: a pomp that barely covers over a deception, an imposture; the masked, official traits of a celebration that does not really concern these lives, which were carried out amid a circle of houses in the hills before the men were called to arms. I look at everyone’s eyes, which have darkened in the photos; I examine the dates and places of the same organized death, shared out into divisions and troops. Someone is missing in action. Perhaps a form of salvation: no longer to be found, to be recognized alongside their identity papers. Free at last. The time that goes by, the emptiness that opens up and takes shape from innumerable roads leading home or to an invisible foreign land, between unknown languages that reach the ear, whispers that resemble those of the dead. But their names are on the list. They have not escaped. They are also here.
I take a few steps outside, towards the crossroads, and consider the three possible directions. I breathe for a moment the vertigo of this supposedly sacred place, defended from demons who are hiding in the foliage of the trees, in the hedges lining the streets, and who shake them like a wind; they shatter the image that we had recognized and kept in the mirror, calling it by our name, detaining it, defending it from the shadows emerging as if from a veil of water. A whisper repeats I in my ear, like the flame of a candle suddenly blown out by the wind. One needs to shelter it with the palm of a hand and walk to the holy image, to the painted mother.
I AM HERE, at the Sanctuary, in the chapel of Our Lady of Graces. At this hour of the afternoon, throughout the entire Sanctuary, only my footsteps and the silent choir of the white candles. The biggest candles crackle up at times, in the silence, as if collapsing, falling back on themselves. Whoever plants them here knows how long their lives last. He can come and look at them as if they were a clock, a calendar. When the oldest one is crushed by time, reduced to the ground like a rind, a cork, suddenly the flame passes to another. In fact there are three candles, each in a different period of its life: the first is almost intact, the second is in the middle, the third towards the end. If you drop a coin into a small steel offering box, a clink resounds as if in a penny bank: you can take a little holy picture with you or a small candle to be planted in the flowerbed along with the others. Nearby is a colony of red candles; graveyards, indeed, but it suffices to look at them for a few seconds to glimpse the tiny protected flame, almost like a life moving slowly in their womb.
You say that praying can also be like this, with a hand making signs on the blank piece of paper.
You say that praying can also be like this, with a hand making signs on the blank piece of paper. It is the same blankness that appeared on a hem of your dress, which erased the mouth of an angel watching over you; it is the blankness from which they have cut you out, which still surrounds you. There we will return, into that void from which you have appeared, from which you appear with big eyes and small lips, in bud. You have a halo carved with geometric patterns, an ancient solar disk; a veil hides your hair. On one knee is sitting a child who is already a man, dressed in green like angels and meadows, watching you clutch a cross. We also look for your eyes, to read the silence on your face.
Among the hearts on the walls, I search, in jest, the initials of my name. I know they have also come here for me. They have knelt at the wooden pew, lit a candle. I was heading towards death, with the instinct of a migrating animal. But even the tiny divinities of the water and the heavens can be tricked: you find them beached, caught in nets, bewildered by their wounds.
Everything that happens is inside your quiet eyes. While our little heart implodes and shatters, it no longer pumps love to the extremities of the body.
Within the silence, only the sounds of an exhaust fan and the cars outside stir the air, like gusts of wind. Before I leave, I return one last time to gaze at your image of moss, ocher, and wet sand. It is as if you had come from the earth, vanquishing the earth, its crumbling. Your eyes will remain, a sign on a peeling wall.
Maria, Verso Cartoceto
È scritto all’anagrafe e in ogni documento che mi appartiene: Maria, il nome che ho cancellato da questa Franca che rimane. Scomparso dalla mia firma. Un solo nome: due sillabe che mi pronunciano, che mi sottraggono al silenzio. Sono già molte per esistere. E anche la voce degli altri mi ha riconosciuto, mi ha chiamata Franca, semplicemente: si è fermata, come non ci fosse bisogno di dire ancora.
Maria è il nome della madre di mia madre. Mi piace sentire l’eco di questa parola, la profondità che apre indietro, nelle generazioni, come un filo che ci si passa nel buio. In questa ripetizione mi sembra di riportarla in vita, di donarle ciò che le appartiene, che le è dovuto; ha a che fare con qualcosa che non ha fine, che sprofonda alle mie spalle, fino a ciò che non mi è visibile né conosciuto. Da me, oltre me, non so come e se continuerà.
Lei è la madre di mia madre, di mia madre, di mia madre. Come scorrendo i grani di un rosario potrei ripeterlo ancora fino a renderla un’espressione muta, un’onda sonora che viene e ritorna nel silenzio. Maria è il nome che ogni donna porta. E davvero nelle nostre campagne marchigiane non c’era madre che non desse a sua figlia questo nome, come invocazione, come ringraziamento. Se non era il primo nome era il secondo, per custodirla.
Ma chiamerò Maria, la madre di mia madre, anche nonna, con l’affetto intatto dell’infanzia, incorniciandola in quegli anni della sua vita in cui ci siamo conosciute. Mi addormentavo spesso accanto a lei, nella metà del letto che era del marito, andato quando avevo quattro anni. Prima di chiudere gli occhi, distese su spesse lenzuola di lino, le sue parole si disegnavano come cerchi nel silenzio; il suo petto era un libro di pagine non numerate che terminavano a un passo dal sonno. Riprendeva la mattina, quando la seguivo nei suoi lavori di casa, in cucina, in cantina, nel pollaio. Tra le sequenze di suoni che ripeteva a memoria c’erano le preghiere. Insieme a queste mi ha insegnato un gesto che assomigliava a quello di legarsi le scarpe: un incrocio che si formava, se eseguito esattamente. Con la punta delle dita si tocca il centro della fronte, il centro del petto, la spalla sinistra e poi la destra. Come un laccio che ti tiene unita, che ti riporta al centro del tuo cuore che è sempre il cuore di un altro. Ogni volta che inizia qualcosa, che ti metti in cammino, segni questa croce su di te come faresti se ti trovassi su una riva, sulla terra bagnata, di fronte a un vetro umido e a ogni altra cosa che può essere scritta. Dice: sono qui, in questo punto esatto. E anche: mi affido a questo tempo e a questo spazio, a questo momento e a questo luogo. Non farmi perdere, tienimi stretta nel tuo sguardo. Chi legga questo messaggio non so dirlo. So che è un segno che presto si cancella, che bisogna ripetere di nuovo. È un po’ come con le scarpe allacciate la mattina per andare. Se le trovi slacciate poi durante il giorno, non puoi andare avanti molto, ti fermi un istante e ricominci.
Gli ultimi anni della sua vita, prima di addormentarsi, mia nonna aveva l’abitudine di chiedere “la benedizione”: una piccola croce che un altro doveva segnarle sulla fronte. Una malattia molto dolorosa, alle ossa, la portava a chiamare a voce alta sua madre, ripetutamente. Accorrevamo a vedere che cosa volesse, di che cosa avesse bisogno; spesso chiedeva di spostare un po’ la tenda, di avvicinarle qualcosa, spesso era soltanto un pretesto per vederci accanto a lei. Da adolescente mi ero quasi abituata a quella litania, e quando mi sembrava solo un capriccio tornavo presto alle mie cose. Chiamava sua madre, noi eravamo soltanto figli, figli dei figli, non potevamo consolarla, sollevarla tra le braccia, stringerla al petto, lontano dal dolore. Una notte, accorsa di malumore al suo richiamo di bambina, con un’irritazione trattenuta che chiedeva che cosa c’è, mi sono sentita chiedere per la prima volta la benedizione. Non c’era nessun altro in casa. Mia madre era uscita dimenticandosene. Toccava a me. A me che già non credevo, che avevo perso quel gesto che mi aveva consegnato come una vecchia chiave di cui non si ricorda la porta. Potevo farlo io? Ne ero capace? Distesa a letto, non poteva abbandonarsi al sonno. Aspettava. Mi aspettava. Nel silenzio mi affidava un potere. Dal fondo della stanza mi sono avvicinata; con un dito le ho tracciato una piccola croce sulla fronte. Sembrava placata, rasserenata. Sono tornata in camera mia.
Ci sono due strade che da Lucrezia portano a Cartoceto. Si attraversa una zona di recenti case residenziali colorate a pastello e ci si ritrova a una biforcazione con due cartelli che indicano la stessa meta. Prendo sempre quella di sinistra, che sembra più breve. Prima di arrivare al paese si sale a Salomone, un nome che continua a ripetersi nella mente cercando qualcosa che richiami l’antico re della Bibbia fino a questa piccola frazione di case, mentre la strada svolta, inizia a costeggiare uliveti e un grande noceto. Si arriva presto a un incrocio a t: la strada da cui veniamo porta a Lucrezia, quella che prenderemo, sulla destra, a Cartoceto, quella a sinistra a Saltara e a Calcinelli. Qui è un monumento ai caduti della prima e seconda guerra: un tempietto chiaro con le pareti laterali interne piene di piccole foto ovali in bianco e nero e scritte che rinviano a una morte declinata in tre casi: per ferite, per malattia, in prigionia. Il luogo: dall’Albania all’Africa, dalla Russia a Creta. Nella parete centrale una lastra di pietra riproduce in rilievo l’immagine della Madonna delle Grazie. È per lei che oggi sono salita qui, a una quindicina di chilometri da Fano, seguendo in auto il cammino che mia nonna faceva a piedi fin da bambina. L’affresco miracoloso era proprio in questo incrocio, in un’edicola, prima di essere staccato e collocato nel Santuario accanto al paese. Riconosco le linee di quell’antico disegno, tante volte ritrovato a casa, sul comodino di mia nonna, dentro un libro, nella credenza. Un santino come un segnalibro, un fiore schiacciato tra le pagine: ricorda il punto fino a cui ti ha portato la vita, il punto da cui puoi continuare. I suoi colori di erba, di polvere e di terra li ritroverò presto nella piccola cappella costruita per lei, con le pareti adornate di cuori d’argento. Non resto a lungo. In questi monumenti ai caduti sento spesso qualcosa di estraneo: un fasto che a malapena riesce a coprire un inganno, un’impostura; i tratti mascherati, ufficiali, di una celebrazione che non riguarda davvero queste vite di uomini trascorse in un cerchio di case tra le colline prima di essere chiamati alle armi. Guardo gli occhi di tutti divenuti scuri nelle foto, seguo la data e il luogo di una stessa morte organizzata, diramata in divisioni e schiere. Qualcuno è stato disperso. Forse una forma di salvezza: non essere più trovati, riconosciuti accanto ai documenti. Finalmente liberi. Il tempo che passa, il vuoto che si apre e si disegna di innumerevoli strade che portano a casa o verso un’invisibile terra straniera, tra lingue sconosciute che arrivano all’orecchio, bisbigli che assomigliano a quelli dei morti. Ma sono tra i nomi dell’elenco. Non sono sfuggiti. Sono qui anche loro.
Faccio pochi passi fuori, verso l’incrocio; considero le tre direzioni possibili. Respiro per un attimo la vertigine di quel luogo che doveva essere sacro, difeso dai demoni che si nascondono nelle chiome degli alberi, nelle siepi ai margini delle strade, scuotendole come un vento; frantumano l’immagine che avevamo riconosciuto e custodito allo specchio, chiamandola con il nostro nome, trattenendola, difendendola dalle ombre che affiorano come da un velo d’acqua. Un soffio di voce all’orecchio ripete io, come la fiamma di una candela subito spenta dal vento. Bisogna proteggerla con il palmo di una mano e camminare fino all’immagine santa, alla madre dipinta.
Sono qui, al Santuario, nella cappella della Madonna delle Grazie. A quest’ora del pomeriggio in tutto il Santuario solo i miei passi e il silenzioso coro delle candele bianche. Le più grandi crepitano a tratti nel silenzio come franando, ricadendo su se stesse. Chi le ha piantate qui conosce la durata della loro vita. Può venire a guardarle come un orologio, un calendario. Quando la più vecchia viene schiacciata dal tempo, ridotta al suolo come una buccia, un tappo, subito la fiamma passa a un’altra. Sono tre infatti, ognuna in un periodo diverso della vita: la prima è quasi intatta, la seconda è a metà, la terza verso la fine. In una colonnina d’acciaio se lasci cadere una moneta ne ricavi un tintinnio metallico come di salvadanaio: puoi portare con te un santino o prendere una candela piccola da piantare nell’aiuola insieme alle altre. Accanto è una colonia di ceri rossi; cimiteriali, è vero, ma basta guardarli pochi secondi per scorgere la minuscola fiamma protetta, quasi una vita che si muove lentamente nel loro grembo.
Dici che si può pregare anche così, con una mano che segna il bianco del foglio. È lo stesso bianco che è apparso a un lembo della tua veste, che si è portato via la bocca di un angelo che ti vegliava; è il bianco da cui ti hanno ritagliata, che ti contorna ancora. Noi torneremo lì, in quel vuoto da cui sei apparsa, da cui appari con occhi grandi e labbra minute, in boccio. Hai un’aureola intagliata di motivi geometrici, un antico disco solare; un velo ti nasconde i capelli. Su un ginocchio è seduto un bambino già uomo, vestito di verde come gli angeli e i prati, ti guarda stringendo una croce. Anche noi a cercare i tuoi occhi, a leggere il silenzio sul tuo viso.
Tra i cuori alle pareti cerco per gioco le iniziali del mio nome. So che sono venuti qui anche per me. Si sono inginocchiati al banco di legno, hanno acceso una candela. Andavo verso la morte, con l’istinto di un animale che migra. Ma anche le piccole divinità del cielo e dell’acqua si ingannano: le ritrovi spiaggiate, prese nelle reti, confuse dalle ferite.
Tutto quanto accade, è dentro i tuoi occhi quieti. Mentre il nostro piccolo cuore implode e si frantuma, non pompa più amore alle estremità del corpo.
Nel silenzio soltanto il rumore di un aspira-fumo e quello delle auto di fuori che spostano l’aria, come raffiche di vento. Prima di andare torno per un’ultima volta a guardare la tua immagine di muschio, ocra e sabbia bagnata. È come se fossi venuta dalla terra, vincendo la terra, il suo sgretolarsi. Resteranno i tuoi occhi, un segno su un muro scrostato.
♦
 Franca Mancinelli was born in Fano, Italy, in 1981. Her first two books of poetry, Mala kruna (Manni, 2007) and Pasta madre (Nino Aragno, 2013), were awarded several prizes in Italy. These two books have now been republished in a single volume, A un’ora di sonno da qui (Italic Pequod, 2018). In 2018, her collection of prose poems, Libretto di transito, appeared at Amos Edizioni, and this same book, in John Taylor’s translation, was published as The Little Book of Passage (Bitter Oleander Press). Some of the translations from the latter collection were initially published in The Fortnightly Review (http://fortnightlyreview.co.uk/2018/03/new-poems-little-book-passage/).
Franca Mancinelli was born in Fano, Italy, in 1981. Her first two books of poetry, Mala kruna (Manni, 2007) and Pasta madre (Nino Aragno, 2013), were awarded several prizes in Italy. These two books have now been republished in a single volume, A un’ora di sonno da qui (Italic Pequod, 2018). In 2018, her collection of prose poems, Libretto di transito, appeared at Amos Edizioni, and this same book, in John Taylor’s translation, was published as The Little Book of Passage (Bitter Oleander Press). Some of the translations from the latter collection were initially published in The Fortnightly Review (http://fortnightlyreview.co.uk/2018/03/new-poems-little-book-passage/).
Franca Mancinelli’s prose text published here was initially published in Femminile plurale: Le donne scrivono le Marche, edited by Cristina Babino, Vydia editore, 2014.
♦
 John Taylor is a contributing editor to The Fortnightly Review. His most recent collections of poetry are The Dark Brightness (Xenos Books, 2017), Grassy Stairways (The MadHat Press, 2017), and Remembrance of Water & Twenty-Five Trees (Bitter Oleander Press, 2018). He has translated several French and Italian poets into English, including Philippe Jaccottet, Pierre-Albert Jourdan, Pierre Chappuis, Pierre Voélin, José-Flore Tappy, Lorenzo Calogero, and Alfredo de Palchi. Odd Volumes, the imprint of The Fortnightly Review, has recently published his translation of Jaccottet’s Truinas.
John Taylor is a contributing editor to The Fortnightly Review. His most recent collections of poetry are The Dark Brightness (Xenos Books, 2017), Grassy Stairways (The MadHat Press, 2017), and Remembrance of Water & Twenty-Five Trees (Bitter Oleander Press, 2018). He has translated several French and Italian poets into English, including Philippe Jaccottet, Pierre-Albert Jourdan, Pierre Chappuis, Pierre Voélin, José-Flore Tappy, Lorenzo Calogero, and Alfredo de Palchi. Odd Volumes, the imprint of The Fortnightly Review, has recently published his translation of Jaccottet’s Truinas.
Note: Photo credits: Top: «The Last Summer / La guerre» (detail) © Diambra Mariani; Second and third photos: © Francesca Perlini.
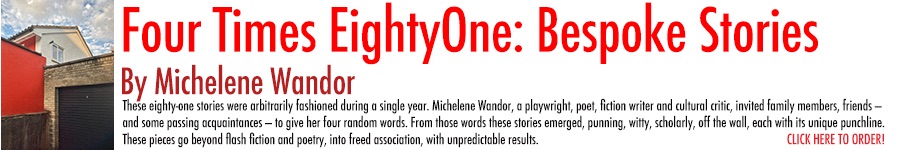























Post a Comment